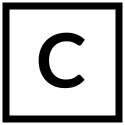CLAUDIA COLOMBO E MAGDA INDIVERI, I due mestieri di Primo Levi
Primo Levi è solitamente ben conosciuto per le opere di testimonianza della Shoah e dei campi di concentramento. Lo affronteremo invece sul versante della tematica lavorativa: uno scrittore-chimico, che più volte in opere narrative e saggistiche ha affrontato questo ambito, ha descritto lavori concreti e ha piegato il suo stile di scrittura sulla base della concretezza e precisione dei dettagli, sempre percependo l’impegno nel lavoro non solo come un dovere, ma come “una salvazione”.
Download Category: Materiali didattici
UN PERCORSO SU CINEMA E LETTERATURA ATTRAVERSO I FILM DEI FRATELLI TAVIANI
GABRIELE CINGOLANI, Tradire la storia, cercare la verità. Due note in forma di didascalia sul cinema dei Taviani e la scuola.
La riflessione sullo statuto della letteratura, e dell’arte in genere, in relazione al vero, sia esso il vero storico o quello del presente, è fondante e propedeutica ad ogni insegnamento umanistico, e arriva sempre il momento in cui, in classe, ci si deve confrontare con questo tema. Un buon modo per farlo è partire da opere di autori che hanno mostrato sia consapevolezza teorica del problema sia capacità di trasformare in opera d’arte compiuta la loro riflessione. Con questa noterella (nata anche dalla volontà di aprire il panel su Letteratura e cinema con un omaggio a due voci – quella di Michela Costantino e la mia – all’arte dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani nella circostanza della scomparsa di quest’ultimo) si vogliono esemplificare – attraverso l’analisi di due fotogrammi tratti rispettivamente da Maraviglioso Boccaccio (2015) e Una questione privata (2017) – le potenzialità offerte dal cinema dei Taviani per la riflessione e la pratica didattica intorno a quattro parole-chiave: cinema, letteratura, storia, presente.
PIRANDELLO NEL CINEMA DEL 900
DOMENICA ELISA CICALA Dalla pagina allo schermo: Pirandello in classe
Dopo una parte introduttiva dedicata alle trasposizioni cinematografiche che adattano per lo schermo vicende narrate nella pagina letteraria, il presente intervento si sofferma sulle potenzialità didattiche di un uso combinato di testi letterari tratti dall’opera di Luigi Pirandello e affiancati a sequenze filmiche dei rispettivi adattamenti, interrogandosi, in particolare, sulle motivazioni e sulle modalità con cui è possibile utilizzare i testi letterari e audiovisivi nell’ambito della lezione di letCicalateratura e cultura italiana rivolta a studenti stranieri.
CANZONI E CINEMA DEL 900
FABIO DE PROPRIS La voce cantata nei film.
Un sondaggio nel Novecento e nel XXI secolo attraverso cinema e canzoni.
L’articolo, ispirandosi alle riflessioni di Corrado Bologna e di Adriana Cavarero, propone un percorso didattico e un suggerimento di ricerca sulla voce umana guidati dalla domanda: a cosa serve la voce cantata in un film? Attraverso l’analisi di alcuni film si pone in evidenza il ruolo del canto all’interno di film non musicali, che è quello di esprimere la più forte emozione, l’individualità di un personaggio, la sua più intima essenza. Si tenta poi di indagare i vari significati che tale emotività può assumere sul piano narrativo e ideologico all’interno del film, suggerendo infine l’estensione dell’analisi al mondo della letteratura scritta.
CINEMA E LETTERATURA: MEDEA E DECAMERON DI P. P. PASOLINI
VITTORIA FOTI Uso didattico del cinema di Pasolini: Medea e Il Decameron
Si presentano due proposte didattiche ed interpretazioni critiche sulla Medea e Il Decameron di Pasolini: il rapporto tra natura, società, religione e cultura nella Medea; per Il Decameron gli studenti saranno guidati ad analizzare la funzione semantica della cornice, riflettendo sul riuso di un testo letterario in un contesto nuovo, con scopi e codici espressivi diversi.
LETTERATURA EPISTOLARE NEL ROMANZO E NEL CINEMA DEL 900
LUISA MIRONE Fasci di lettere da Una giornata particolare
Quattro studentesse di quarta Liceo scientifico, alle prese con un concorso di scrittura narrativa che invita a riflettere sulle ‘vittime collaterali’ delle guerre, vengono guidate nell’analisi del film di E. Scola Una giornata particolare. Inizia da qui il percorso che le condurrà, attraverso le narrazioni di R. Viganò (L’Agnese va a morire) e di E. Morante (La storia), a inseguire l’ultima corsa di Pina-Anna Magnani in Roma città aperta di Rossellini, ad ascoltare la lettera che chiude Anni ruggenti di L. Zampa e leggere le lettere di uomini e donne comuni, indirizzate o meno al Duce, sino a immaginare di scriverne una, anzi di essere una di loro.
SCUOLA DIGITALE E RAPPRESENTAZIONI FILMICHE E TELEVISIVE DELL’INSEGNANTE
STEFANO ROSSETTI , La scuola allo specchio
Questa relazione costituisce la seconda parte di una più ampia argomentazione, che ha per tema la rappresentazione della figura dell’insegnante, introdotta e sviluppata (sotto l’aspetto della narrativa) da Cinzia Ruozzi.
Nella prima parte, si richiamano alcuni riferimenti concettuali utili ad una seria riflessione metodologica sull’utilizzo di strumenti e prodotti audiovisivi nella didattica, in particolare nel contesto dell’attuale promozione della “scuola digitale”. Successivamente, la riflessione si concentra sull’importanza decisiva di alcune rappresentazioni filmiche e televisive nella formazione di un’opinione pubblica sulla scuola e sull’insegnante. Questo processo viene illustrato in relazione a diversi contesti mediatici e storico-culturali, analizzando esempi significativi.
RAPPRESENTAZIONE DELLA SCUOLA ANNI 50 E 60 NEI ROMANZI DI BERNARDINI E ONOFRI.
CINZIA RUOZZI, La scuola allo specchio. Rappresentazione e realtà della professione docente nella narrativa di Albino Bernardini e Sandro Onofri
Il presente contributo si propone di indagare le forme letterarie attraverso le quali si è espresso il racconto della scuola: diari, lettere, cronache, saggi, pamphlet, ricordi, dizionari per voci nella convinzione che il resoconto di quanto avviene in una giornata o in un anno scolastico non sia unicamente il racconto di )un vissuto personale, ma la rappresentazione di un luogo paradigmatico, lo spazio di un particolare che riflette l’universale. Nello specifico ci si soffermerà su due grandi interpreti del racconto di scuola: Albino Bernardini e Sandro Onofri, che rappresentano due momenti topici della storia della scuola italiana: gli anni Cinquanta-Sessanta, quando comincia il processo di alfabetizzazione di massa; e gli anni Duemila, momento in cui inizia la crisi della scuola di massa.
IL GIULLARE COME MODO DI VIVERE E INTERPRETARE IL MONDO DAL 200 A DARIO FO E PEPPINO IMPASTATO.
RITA SEPE Nuovi doveri per un mondo alla rovescia.Le proposte di Francesco giullare di Dio
Attraverso il Gran Lombardo di Conversazione in Sicilia Elio Vittorini esprimeva l’esigenza di compiere altri, nuovi doveri per combattere il dolore del mondo offeso. Erano gli anni del regime fascista e della guerra civile spagnola, e con il falso reportage da Malaga l’autore aveva criticato la posizione assunta da Mussolini in quel conflitto. Ma ci vengono richiesti nuovi doveri anche oggi, quando facciamo i conti con una società per molti versi distopica, nella quale i nostri giovani si muovono spesso senza la consapevolezza di vivere in un mondo alla rovescia e dichiarando una mancanza di fiducia nel futuro, e ci interpellano con nuovi bisogni educativi. Interessante a questo scopo può essere un percorso tra letteratura, cinema e teatro attraverso la figura del giullare nel passato e nel presente. Partendo da Francesco d’Assisi e dal Cantico delle creature, e dalla loro rilettura in opere cinematografiche (Francesco giullare di Dio di Rossellini) o teatrali (Lu santo jullare Franzesco di Fo), si scoprirà come sia possibile guardare e mostrare il mondo da un’altra prospettiva e vivere perciò valori altri da quelli costituiti. E come il punto di vista del giullare rappresenti un osservatorio privilegiato ed efficace in quanto straniante, lo dimostra la scelta di accostare questo appellativo ad un uomo simbolo della lotta contro la mafia come Peppino Impastato compiuta da Rizzo e Bonaccorso nel loro Un Giullare contro la mafia.
IL TEMA DEL CORPO NELLA COMMEDIA DANTESCA
RAFFAELLA ROMANO, Non solo occhi: il corpo e la sua funzione nella Divina Commedia